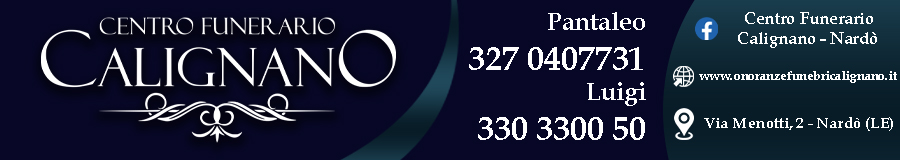La sindrome di Stoccolma è una peculiare condizione psichica in cui le vittime di un rapimento si affezionano ai loro sequestratori.
La sindrome di Stoccolma è una peculiare condizione psichica in cui le vittime di un rapimento si affezionano ai loro sequestratori.
La sindrome di Stoccolma rappresenta un paradosso del comportamento umano: l’ostaggio che ne è interessato, infatti, avverte simpatia, comprensione, empatia, fiducia, attaccamento e talvolta perfino amore nei confronti del suo rapitore, quando invece sarebbe più logico che provasse sentimenti come odio, avversione, antipatia, volontà di non assoggettarsi.
In questi giorni, sentiamo spesso parlare del caso di Silvia Romano, la volontaria italiana rapita il 20 novembre 2018 e liberata dopo oltre 500 giorni di prigionia.
Fonti investigative non escludono che possa «trattarsi di una situazione psicologica legata al contesto in cui la ragazza ha vissuto per lungo tempo, non necessariamente destinata a durare nel tempo». La sindrome di Stoccolma, per l’appunto.
Questo termine è stato coniato da Conrad Hassel, agente speciale dell’FBI, in seguito ad un episodio accaduto in Svezia tra il 25 ed il 28 agosto del 1973: due rapinatori tennero in ostaggio per 131 ore quattro impiegati nella camera di sicurezza della Sveriges Kreditbank di Stoccolma.
Nonostante la loro vita fosse continuamente messa in pericolo, durante il periodo di prigionia, che fu seguito con particolare attenzione dai mass media, risultò che le vittime temevano più la polizia di quanto non temessero i rapitori, tanto che una delle vittime sviluppò un forte legame sentimentale con uno di loro (che durò anche dopo l’episodio).
Inoltre, dopo il rilascio, venne chiesta dai sequestrati la clemenza per i sequestratori e durante il processo alcuni degli ostaggi testimoniarono in loro favore.
Questa Sindrome può interessare ostaggi e rapitori di ogni età, di ambo i sessi, di ogni nazionalità e senza distinzione socio-culturale. Alcuni fattori ne faciliterebbero l’insorgere: la durata e l’intensità dell’esperienza, la dipendenza dell’ostaggio dal delinquente per la sua sopravvivenza e la distanza psicologica dell’ostaggio dalle autorità e dai familiari.
Sembrerebbe che il legame affettivo tra rapitore e rapito non si formino subito, ma si rivelino già abbastanza solidi entro il terzo giorno di prigionia. Questo potrebbe essere giustificato dal fatto che, nei primi momenti dopo il sequestro, il rapito sperimenti un totale stato di confusione, riscontrabile anche in alcune risposte tipiche al trauma: diniego, illusione di ottenere la liberazione, attività frenetica ed esame di coscienza.
Una volta superato il trauma iniziale, la vittima torna consapevole della situazione che sta vivendo e deve trovare un modo per sopportarla e adeguarsi.
Questo favorisce l’inconscia alleanza col sequestratore. L’assenza di forti esperienze negative, come percosse, violenza sessuale o abuso fisico, facilita la genesi della sindrome.
Oggi non si conosce ancora con precisione la durata di questa Sindrome, ma pare possa sussistere anche per molti anni. Poiché strettamente correlata al trauma, è associata al disturbo da stress post-traumatico e, quindi, viene trattata con psicofarmaci e psicoterapia. Gli strascichi del disturbo possono provocare disturbi del sonno, pavor nocturnus, fobie, attacchi di panico, flashback e depressione.
Le cause della Sindrome di Stoccolma non sono molto chiare. Sono state date varie spiegazioni a questo fenomeno: alcuni ritengono che questo legame derivi dallo stato di dipendenza concreta che si sviluppa fra il rapito ed i suoi rapitori, che controllano cibo, aria, acqua e sopravvivenza, elementi essenziali, rinforzi che, da un punto di vista comportamentale, quando vengono concessi, giustificherebbero la gratitudine e la riconoscenza che gli ostaggi manifestano nei confronti dei loro carcerieri.
La maggior parte degli autori affrontano, però, il tema, da un punto di vista psicodinamico: l’Io, nel tentativo di trovare un equilibrio fra le richieste istintive dell’Es ed una realtà angosciosa, non può far altro che mettere in atto meccanismi di difesa, mossi dal fisiologico spirito di sopravvivenza.
La Sindrome di Stoccolma non è codificata in nessun manuale diagnostico. Eppure, sarebbe interessante tentare di approfondirne le cause, indagando gli stili di attaccamento e i profili comportamentali dei soggetti che hanno vissuto lo stato di identificazione vittima-carnefice, così da permettere agli operatori della salute mentale di guardare con occhi diversi situazioni analoghe.